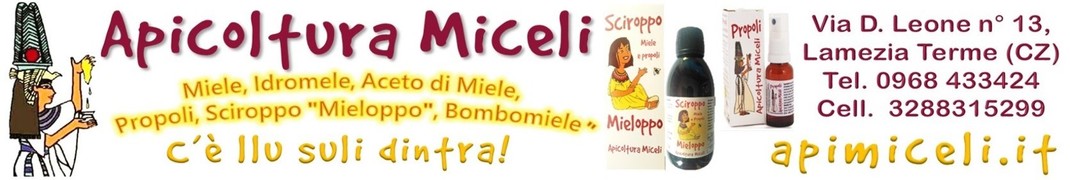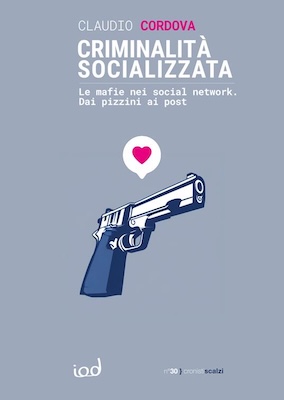Mafie e comunicazione, un legame inscindibile
Claudio Cordova, giornalista e direttore della testata online “Il Dispaccio”, torna in libreria con un nuovo saggio: “Criminalità socializzata. Le mafie nei social network. Dai pizzini ai post” (IOD, 2025) – una nota di merito va alla casa editrice e ai titoli inseriti nella collana “Cronisti scalzi”, dedicata alla memoria di Giancarlo Siani –, dimostrando, se mai ce ne fosse bisogno, ancora una volta di essere uno dei pochi giornalisti ad avere il coraggio di andare in fondo a ogni questione si prenda a cuore. Sono di parte mentre scrivo? Sì, e lo dichiaro pure con una certa punta di orgoglio, perché ho conosciuto Claudio quando era solo un praticante giornalista e dopo qualche lustro gli riconosco ancora la passione e l’impegno di essere rimasto uno dei pochi a scavare fra argomenti spinosi, necessari ma con cui quasi più nessuno ha voglia di sporcarsi le mani. Questa premessa per potermi permettere di iniziare il commento a questa sua nuova opera scrivendo che – finalmente! – Cordova si è liberato dai lacci strutturali della cronaca giudiziaria e ha lasciato che la penna scorresse leggera sul foglio. “Criminalità socializzata” è un viaggio dalle origini delle mafie, un’analisi dei valori identitari che le caratterizzano e rendono un fenomeno secolare che le permettono di resistere ed evolversi, nonostante proprio questi suoi valori dovrebbero renderla impermeabile agli agenti esterni.
L’argomento è complesso, più vasto di quanto si pensi: siamo abituati a pensare alle mafie come a qualcosa di occulto, un’azione sotterranea di cui possiamo solo vedere gli effetti (e in parte così è), mentre in realtà, dalle sue origini agropastorali, ha compiuto balzi in avanti, fra un capitolo e l’altro notiamo come abbia saputo evolversi più della società civile, stare al passo coi tempi, modernizzarsi, pure restando ancorata ai suoi diritti e doveri tradizionali.
Il saggio ci introduce alle origini, al limite del mitologico, del fenomeno mafioso; ce ne dipinge un quadro i cui protagonisti sono gli uomini, una famiglia ‘allargata’ ma dalle maglie strettissime il cui principio cardine di sopravvivenza è l’omertà. E qui ci scontriamo con il primo paradosso: come può un sistema basato sul silenzio essere diventato tanto pervasivo, essersi aperto al mondo dei social e della comunicazione mainstream? La risposta ce la dà Giovanni Falcone: «La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine». Al momento, siamo nella fase evolutiva e si spera sia quella che riuscirà ad avvicinare il più velocemente alla fine. Ma tant’è che siamo ancora qui a parlarne, a visitare tra le pagine i luoghi simbolici della cultura della ‘ndrangheta, di Cosa Nostra e della Camorra, i riti grotteschi e le storie che sono diventate film, brani musicali sotto l’unico brand del potere senza ritegno.
I social media sono diventati lo specchio in cui riflettere l’immagine di una vita apparentemente perfetta, tra lusso sfrenato e spregio a ogni regola, a mostrare il vanto del disprezzo della legalità. Sono soprattutto le giovani leve ad aver intuìto come gli strumenti digitali possono essere una bacheca per esporre il fantastico mondo del crimine, un mezzo per eludere le intercettazioni, uno spot a costo zero per il reclutamento di manovalanza, spesso ignara e ignorante che non riesce a percepire neanche dove stia la testa della piovra che li sta accalappiando. Personalmente, andando a spulciare e approfondire alcuni degli esempi che Cordova riporta nel testo, ho avuto più volte il dubbio se quello che stessi vedendo o ascoltando non fosse altro che un esempio di pessimo gusto, braccia rubate alla pastorizia più che all’agricoltura o una fauna che ha geneticamente eluso la razza umana.
Ed è qui che si inserisce la disamina, negli ultimi capitoli, di come ci siano sfuggiti di mano lo stile e le parole che raccontano le mafie, fino ad arrivare alla «sciatteria» della mera informazione. Ma nel frattempo dove eravamo? Qualcuno incollato al televisore a guardare “Gomorra” (Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, ndr) e qualcun altro ad ascoltare lo sgrammaticato di turno uscito da “Case pacchiane” (interior designing a cura dei Casalesi – e Padre, non perdonare loro, ché sanno quello che fanno e noi non l’abbiamo ancora capito, ndr-).
Abbiamo addossato le parole e la memoria delle vittime di questa gentaglia alle famiglie delle vittime, li abbiamo gravati della responsabilità di raccontare il loro dolore sperando che fosse uno strumento di persuasione che indicasse la retta via, dimenticando che anche quelle famiglie sono vittime a loro volta. Ed è forse il capitolo dedicato all’informazione ufficiale, al giornalismo non più puro quello che mi ha colpito di più, che più mi ha dato da riflettere su come l’uso sbagliato del linguaggio, la sua semplificazione fino alla mortificazione abbia arredato le vetrine social delle mafie.
Chi si occupa soprattutto di alcune tematiche dovrebbe ricordare a sé stesso quel che scrisse nei suoi appunti il giudice Rosario Livatino: «Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili». E al Cordova auguriamo di mantenere ancora a lungo sempre alta la credibilità che lo contraddistingue, senza se e senza ma.
LETIZIA CUZZOLA